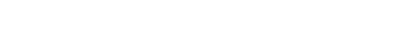SANTA TROFIMENA, L'ANIMA DI MINORI
Ogni cittadina della Costiera Amalfitana possiede un patrimonio culturale, che ha forgiato l’identità di ogni singola comunità. La piccola Minori associa la propria storia e tradizione alla protettrice Trofimena, una giovane martire cristiana, giunta dal mare, accolta nel cuore dei minoresi e divenuta simbolo peculiare del borgo costiero. In questo articolo scopri le origini del culto, le leggende legate al suo arrivo e il legame profondo che ancora oggi unisce la santa al borgo di Minori.
di R. Troiano
La vergine e martire Trofimena rappresenta un tesoro prezioso, attorno a cui la comunità di Minori ha formato la propria identità culturale. La giovane santa siciliana, originaria della amena cittadina di Patti, subì il martirio durante il III secolo dopo Cristo, abbracciando la fede cristiana e rinunciando al progetto paterno di sottostare ad un patrizio locale, che l’aveva chiesta in sposa.
La sua storia intreccia quella di Minori solo diversi secoli dopo, intorno alla metà del VII secolo, quando – come racconta lo storico locale Pompeo Troiano – il suo corpo fu rinvenuto sulla spiaggia del paese, custodito in una cassa. Da quel giorno Trofimena e Minori sancirono un connubio, che plasmò l’intero borgo, definendo la fisionomia della sua società e delle sue tradizioni.
share this article
La Chiesa di Santa Trofimena
Un esile corpo forma l’anima di una comunità
Indagare la storia di santa Trofimena permette anche di delineare la struttura del paese, che da secoli l’ha accolta e custodita nel suo grembo.
Lo storico Giuseppe Gargano racconta che “il primitivo abitato di Forcella fu abbandonato al tempo in cui avvenne il miracoloso ritrovamento delle spoglie di S. Trofimena sulla spiaggia sottostante.”¹. Minori iniziò così a crescere attorno al luogo di culto della giovane martire, diventando poco a poco una comunità che si identificava nella presenza e nella protezione della santa giunta dal mare.
Pochi anni dopo l’arrivo delle reliquie, la Costiera Amalfitana subì l’invasione del principe longobardo Sicardo e perciò il corpo di Trofimena fu trasferito nella cattedrale di Amalfi su iniziativa del vescovo della città, Pietro II.
Il prezioso tesoro non sfuggì tuttavia alla razzia dei longobardi, che nell’839 invasero e saccheggiarono Amalfi. Le spoglie di santa Trofimena furono così traslate a Benevento da Sicardo “per nobilitare con le preziose reliquie la propria chiesa e fornire alla città una ulteriore divina protezione.”²
Il ritorno della santa a Minori avvenne appena un anno dopo. Con la morte del principe longobardo, nell’840, una delegazione di chierici ottenne nuovamente una parte delle reliquie. Come riporta lo studioso Giuseppe Imperato, “all’alba del 13 luglio avvenne la definitiva traslazione a Minori”³ e tuttora la comunità minorese ricorda quel giorno gioioso, quando riaccolse la propria luce, affinché rifulgesse ancora sulla quotidianità del proprio paese.
Il secondo ritrovamento: il desiderio di un incontro
La storia di Trofimena proseguì ancora negli anni successivi e tra le ricorrenze impresse nella tradizione di Minori risulta significativa la data del 27 novembre, quando i minoresi ricordano il secondo ritrovamento delle reliquie, avvenuto nel 1793.
Durante la seconda metà del XVIII secolo fu edificata l’attuale Basilica del paese, modificando la precedente struttura della chiesa madre. Nella notte tra il 26 e il 27 novembre del 1793, alcuni abitanti di Minori riportarono alla luce l’altare, dove erano state custodite le sacre spoglie nel timore che fossero nuovamente trafugate e la cui memoria era stata dispersa nei secoli.
Un nome denota la propria storia e quella di una comunità
Trofimena ha forgiato la storia e la spiritualità di un intero popolo. Basti anche solo annotare che, nel 987, proprio a motivo della sua presenza, Minori fu elevata a sede vescovile. Persino il suo nome parla del suo legame con la comunità: etimologicamente, infatti, Trofimena significa “colei che è stata nutrita”. Un significato simbolico e profondo, perché la santa ha dispensato grazia verso la comunità a cui è stata donata secondo un ignoto disegno e alimenta ancora oggi l’identità di ogni minorese.
share this article
1. Gerardo Sangermano, Minori, Rheginna Minor. Storia, arte, culture, De Luca editore, Salerno 2000, pag.15.
2. Gerardo Sangermano, Minori, Rheginna Minor. Storia, arte, culture, De Luca editore, Salerno 2000, pag.43.
3. Gerardo Sangermano, Minori, Rheginna Minor. Storia, arte, culture, De Luca editore, Salerno 2000, pag.149.